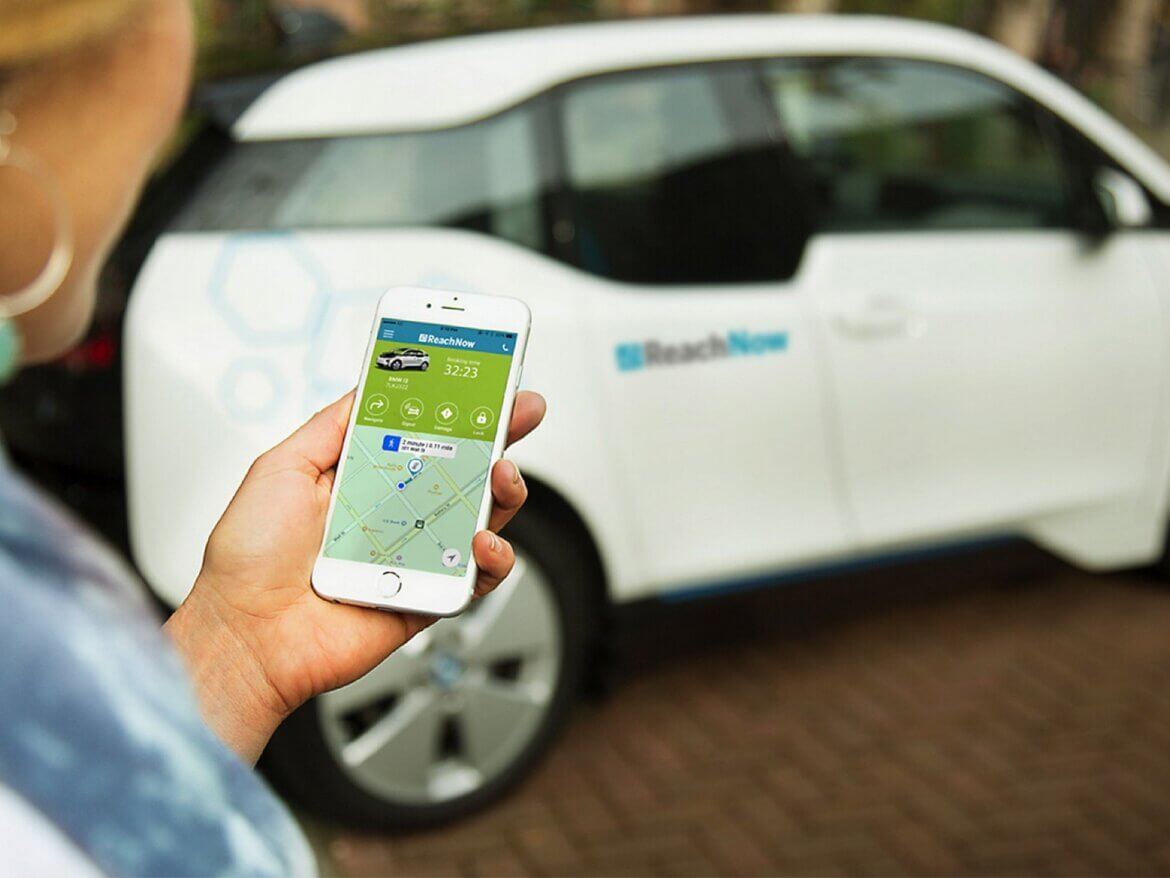Dall’indagine condotta dall’ISTAT nel 2018 emerge che il 70% delle aziende italiane hanno già adottato sistemi di welfare aziendale, per molteplici e diverse ragioni: alcune per migliorare la propria reputazione ed immagine aziendale, altre per ottenere sgravi e vantaggi fiscali dallo Stato, altre per contenere le emissioni di CO2 (attraverso sistemi di trasporto collettivi come carpooling o carsharing a livello corporate) ed infine vi è chi, per davvero, intende migliorare le condizioni di lavoro e quindi di produttività dei propri dipendenti. Le pratiche del 2018 più utilizzate dagli imprenditori hanno visto in primis la concessione di una più vasta flessibilità degli orari di lavoro (68,6%) e, quasi a pari merito, troviamo corsi di formazione/approfondimento per i dipendenti (65,6%). Altri interventi, legati maggiormente alla conciliazione lavoro-vita privata dei lavoratori (ad esempio congedi parentali, smart working ecc…), non hanno visto risultati eccellenti, anzi le percentuali si aggirano tra il 30% e il 2,5% se si parla di asili nido aziendali o forme analoghe di supporto per le famiglie lavoratrici. Inoltre, guardando la cartina geografica, si deduce che talune misure di welfare vengono applicate con una certa frequenza dalle aziende del nord – e meno invece nel Mezzogiorno – e più le dimensioni delle medesime sono importanti, più hanno risorse e capacità tali da poter attuare politiche mirate.
Alla luce di questi dati, possono essere fatte alcune considerazioni. In primo luogo, al fine di estendere le misure di welfare aziendale anche alle realtà aziendali più piccole che più faticano ad allinearsi, è auspicabile creare dei network solidali di modo che le aziende più virtuose possano sostenere quelle meno virtuose, all’interno di un sistema fatto di share and give, di collaborazione reciproca e condivisione di buone pratiche. In secondo luogo, promuovere un approccio lavorativo flessibile come sinonimo di maggiore produttività, sia del dipendente che per l’azienda nel suo complesso. Vuol dire, altresì, creare le basi per un rapporto di lealtà e fiducia tra datore di lavoro e dipendente inedito rispetto al passato, capace di scardinare vecchie concezioni e cliché (se non riesco a controllarti non so se stai davvero lavorando oppure chi mi garantisce che non si possano replicare analoghi casi ai “furbetti del cartellino”?). Certamente le eccezioni ci saranno sempre: senza dubbio, il mondo di oggi possiede strumenti e tecnologie all’avanguardia in grado – o prossimi ad esserlo – di vigilare, di introdurre sistemi di controllo, anche a distanza, per scongiurare, in taluni contesti, il verificarsi di fenomeni a quelli poc’anzi illustrati.
Lo smart working, attuato massicciamente durante la pandemia come misura volta a circoscrivere il contagio, ha evidenziato come in realtà i lavoratori hanno spesso lavorato oltre il consueto orario, anche in fasce serali, organizzando la propria giornata come meglio ritenevano, ma senza venir meno ai propri doveri di lavoratori diligenti (fatte salve alcune eccezioni). Il lavoro agile probabilmente lascerà traccia di sé anche dopo la pandemia, in misura variabile dalle due alle tre volte a settimana ed a seconda dei vari contesti. Sarà difficile tornare indietro quando ormai questa modalità è diventata o diventerà, per alcune aziende, parte integrante dei piani aziendali, oltreché modalità già sperimentata dai lavoratori che ne hanno così constatato i benefici: meno stress, più semplicità nel conciliare lavoro e vita privata, una migliore organizzazione della giornata lavorativa, zero ore spese nel traffico cittadino e, dunque, ambiente più salubre, minor inquinamento ambientale ed acustico. Tuttavia, è doveroso rimarcare che andrà ricercato un delicato equilibrio tra lavoro in ufficio e lavoro agile, affinché quest’ultimo non diventi totalmente alienante.
La flessibilità oggi rappresenta un’opzione, una libera scelta dell’azienda; fra qualche anno diventerà un’opzione cogente dettata dalle circostanze, auspicabilmente più mature di quelle odierne.