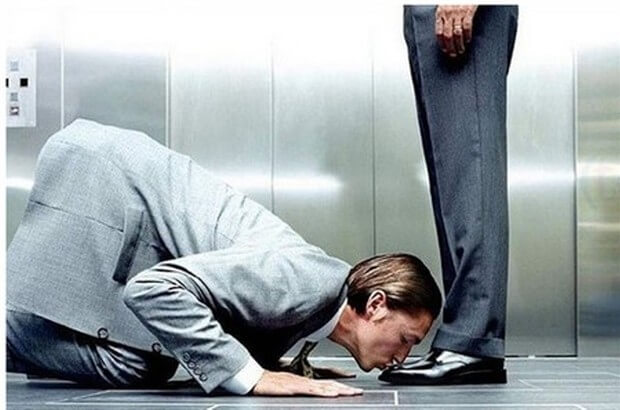Merita una breve riflessione la pronunzia n. 28603 resa dalla Corte di Cassazione, VI° sez. pen., in data 28.03.2013 e pubblicata il 3.7.2013, in quanto offre l’opportunità di parlare dello “straining” (termine di derivazione inglese che allude allo stato di stress psico – fisico indotto da un illegittimo atto del datore di lavoro) e di fissarne i tratti distintivi rispetto alla similare fattispecie di “mobbing”.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Supremo Collegio, il ricorrente, dipendente di una importante banca nazionale, soccombente sia in primo grado sia in grado di appello, lamentava di essere stato privato delle sue mansioni presso l’unità di “Customer Care” presso cui operava e di essere stato quindi relegato in uno sgabuzzino “sporco e spoglio”, con mansioni dequalificanti e meramente esecutive: il che, a detta del ricorrente, integrava il reato di cui all’art. 572 c.p. (“Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”), sul presupposto che il contesto lavorativo in cui era maturata la sua emarginazione era assimilabile a un ambiente para – familiare, con relativa applicazione della citata norma incriminatrice.
La Suprema Corte, nel rigettare una tale assimilazione in considerazione della dimensione multinazionale della banca datrice di lavoro, richiama, per la prima volta in sede di legittimità la nozione di “straining”, che sino ad ora, era stata enucleata in poche sentenze di merito, la più importante delle quali, per il suo carattere innovativo, è la n. 286/2005 dal Tribunale di Bergamo.
Lo straining, in via di prima definizione, può essere definito come una forma attenuata di mobbing, parimenti riconducibile, sul piano normativo, sia alla nozione di “molestia” contenuta nei DD. Lgs. nn. 215 e 216 del 2003 – dovendosi intendere con tale espressione qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l’effetto di violare la dignità delle persone e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo (art. 2, comma 3, dei citati Decreti) – sia, soprattutto, al principio generale contenuto nell’art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Salvo il comune fondamento normativo della fattispecie di “straining” e di quella di “mobbing”, le due ipotesi non possono considerarsi, però, perfettamente coincidenti sul piano strutturale.
Ed infatti, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia di “mobbing”, ai fini della configurabilità in tali termini della condotta lesiva del datore di lavoro è necessario che ricorrano i seguenti elementi: una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, caratterizzati da sistematicità e da reiterazione nel tempo (almeno 6 mesi, secondo l’indirizzo predominante); l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; il nesso di derivazione causale tra le suddette condotte persecutorie e il pregiudizio alla integrità psicofisica del lavoratore e, infine, l’intenzione persecutoria del mobber (tra le tante: Cass. 23.05.2013, n. 12725; Cass. 2.4.2013, n. 7985; Cass. 23.7.2012, n. 12770; Cass. 10.1.2012, n. 87; Cass. 27.12.2011, n. 28962; Cass. 31.5.2011 n. 12048; Cass. 26.3.2010, n. 7382; Cass. 17.2.2009, n. 3785; Cass. 9.9.2008, n. 22858).
Lo “straining”, diversamente dal “mobbing”, non richiede una pluralità di atti persecutori, posti in essere con carattere di sistematicità e di progressività in un arco temporale di almeno sei mesi, ma si esaurisce in poche e sporadiche azioni ostili, anche in una soltanto al limite, a condizione, però, che da esse derivino conseguenze negative durature nel tempo per la vittima
In altre parole la frequenza temporale, che nel caso del mobbing deve connotare le azioni ostili del datore di lavoro, nel caso dello “straining” assume, invece, valenza qualificatoria con riferimento alla durature ripercussioni negative che l’illegittimo atto datoriale ha provocato.